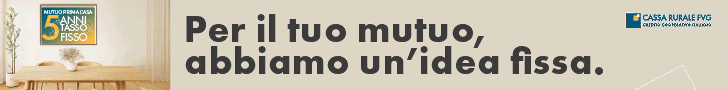LA PROIEZIONE
‘The Truth on Sendai City’ apre la riflessione sullo spettro delle guerre e la dissoluzione delle democrazie

Dallo stereotipo di ‘Metropolis’ e ‘Blade Runner’, il lungometraggio d’animazione di Marco Bolognesi e del direttore di fotografia Daniele Ciprì promuove la riflessione sugli scenari attuali. Il film è stato presentato ieri sera al Kinemax di Gorizia alla presenza del regista.
Dall’arte contemporanea al cinema d’animazione per adulti, Marco Bolognesi nasce come disegnatore e modellista fino a divenire fotografo, partecipando a mostre e festival ed esponendo i lavori anche alla Collezione Farnesina e all’Oscar Niemeyer Museum. Classe 1974 e una dura gavetta nel mondo del cinema, si laurea al DAMS di Bologna con una tesi su Peter Greenaway fondando nel 2017 la Bomar Studio, con cui produce e distribuisce lavori di videoarte e cinema. Recente è la sua collaborazione con il regista, sceneggiatore e cineoperatore Daniele Ciprì per realizzare “The Truth on Sendai City”, una città distopica fondata su Ordine, Benessere e Sicurezza. Il film è stato proiettato giovedì 11 settembre al Kinemax di Gorizia nell’ambito di Progetto Amnesie Go! 2025, grazie al quale è stata anche allestita una mostra con un centinaio di fotogrammi dell’autore. La serata si è svolta alla presenza dello stesso Bolognesi, che a conclusione della proiezione ha approfondito con il pubblico segreti e tecniche di lavorazione del suo primo lungometraggio.
Dalla scultura alla fotografia o al cinema. Come inizia questa passione per il linguaggio dell’animazione? Sono nato come disegnatore, poi son divenuto fotografo, e da lì sono esploso a livello di mercato lavorando nelle gallerie londinesi con Vivienne Westwood. A Londra ero andato con l’idea di fare il fotografo di moda. Nel 2000 vinsi l’Artist in Residence e collaborai con gli stilisti italiani e inglesi con una mostra inserita nel “catwalk” della London Fashion Week. Lavorai con stilisti come Armani o Dolce &Gabbana, e poi con la Westwood per realizzare concept photo. Da lì lasciai il mondo della fashion per lavorare nelle gallerie: fra il 2005 e 2006 ebbi un’esplosione positiva, aprii lo studio e iniziai a lavorare solo per le gallerie d’arte con fotografie, video e installazioni. Fra 2008 e 2009 iniziai a realizzare uno storytelling del mondo che avevo creato: un universo legato al post-human, all’identità umana e al corpo che si modificava in quanto entità. Proiettando le tematiche presenti sul futuro con un linguaggio che facesse riflettere il pubblico. Con la casa di produzione ho avuto la possibilità di creare le mie storie e i miei film, anche se in realtà la mia gavetta è partita dal cinema fin dagli anni universitari, lavorando con la Fandango o a Cinecittà con i direttori di fotografia.
Quanto tempo è durato il lavoro su oggetti, disegni e trasformazione in animazione 2D?
Gli oggetti dei miei film sono installazioni decontestualizzate e diventate set del film. La città di Sendai è un’installazione di sei metri per tre presentata in diversi musei. Sono un modellista per passione, cresciuto da ragazzino con Dungeons&Dragons e ho avuto l’idea di costruire armate. Avevo quindici o sedici anni, durante campionati di Wargames ci insegnavano a creare gli scenari di combattimento che erano plastici mobili. Questa tecnica l’ho affinata e portata nella mia arte - le astronavi le ho costruito con quei materiali di recupero – diventando elemento importante. Nello stesso cinema di Margheriti, Bava o altri si usava la tecnica dei mockup, oggetti per creare effetti speciali. Le mie non sono vere e proprie sculture, quanto piuttosto installazioni. Il film ha avuto i tre anni di produzione vera, anche se ne abbiamo impiegato altri due. Dalla nascita della società nel 2017 abbiamo iniziato fin da subito a lavorare ai disegni, perché è un lavoro lungo.
I fotogrammi di queste clip vengono trasformati in fotocopie, a loro volta colorate a mano a passo quattro, ottenendo sei fotogrammi al secondo. Le fotocopie vengono tutte colorate a matita, poi i personaggi vengono scontornati per inserire occhi e bocche per il labiale. E infine vengono immessi in un’altra scenografia, a sua volta disegnata. In tutto sono 70mila disegni, che iniziai da solo. Man mano che recuperavo fondi avevo sempre più assistenti ad aiutarmi a completare il film. Tutte le scene esterne sono invece realizzate con modellini - gran parte dei quali sono mie creazioni o installazioni – ripresi da Daniele Ciprì. Questo a livello tecnico, mentre a livello teorico ciò che mi preme è manipolare il linguaggio per crearne uno nuovo, partendo dall’idea che avevo già realizzato lavori su pellicola: infatti quando la cineteca di Bologna mi regalava pellicole destinate al macero, li recuperavo per farci nuove storie. L’idea era manipolare il cinema, facendo diventare una storia un’altra storia attraverso un percorso fluido. Io stesso sono cresciuto con programmi quali Fuori Orario o Blob, che portano ad appropriarsi di un determinato linguaggio.
Oltre a strizzare l’occhio ai disegnatori giapponesi, "Sendai City" attinge al cinema muto e a quello contemporaneo. Come la classe operaia di “Metropolis” di Lang vive nel sottosuolo - governata da Joh Fredersen - così il Grande Cervello domina gli schiavi che si nascondono nel settore sotterraneo di “Metropolis”. Fra analogie filmiche e metafore, il film rispecchia in maniera cupa il nostro tempo, dominato dallo spettro delle guerre e dalla dissoluzione delle democrazie. Che strada sta per intraprendere quest’umanità?
Sì, all’interno del film ci sono tanti aspetti, come dici, che guardano a una letteratura diversa. “Metropolis” è diventata un paradigma: non è solo la città di Fritz Lang, ma ormai è uno stereotipo. Nel nostro immaginario la riflessione si è basata su testi di Orwell, che – ahimé - è diventato contemporaneo. In questo film abbiamo la stessa storia narrata da tre punti di vista diversi. Che raccontano l’amore di un uomo per la sua compagna e ciò che fa per salvarla, il potere di una generalessa e la libertà di questa ribelle che tenta di contrapporsi alla tirannia. Le tre storie si mescolano per riportare uno sguardo a 360 gradi senza giudicare nessuno. Per spingere il pubblico a riflettere sul come siamo vittime e carnefici della nostra realtà quotidiana. Un mondo che è contemporaneo e attuale, presente. Non ho pensato a un Paese specifico, ma ho aggiunto elementi diversi per ricordare elementi del nostro contemporaneo. “Metropolis” mostra l’urbanizzazione, la città che non dà spazio, dove vengono portati gli scarti della società. Per costruire il modellino mi sono ispirato alla struttura del Barbican di Londra, che all’epoca era molto popolare.
La nostra è una cultura abituata alla violenza costante, e la scelta dell’animazione da un lato la rende più “soft”, dall’altra colpisce quella parte più intima della nostra interiorità. Se avessi raccontato la storia con un documentario sarebbe stato l’ennesimo sulla violenza, mentre ho cercato di raccontarla s’un altro piano. Al di là dell’aspetto visionario, sentivo di dovermi porre in un’altra posizione, altrimenti avrei corso il rischio di non essere ascoltato. Ho cinquant’anni, e per cinquant’anni al telegiornale ho visto palestinesi morire tutti i giorni. Per la tua sopravvivenza crei un allontanamento e ti sembra normale che questa povera gente muoia. Crei una lontananza, perché non puoi sentire dolore tutti i giorni. Per parlare di questi argomenti devi inventarti soluzioni alternative, e non a caso nel film ci sono i ribelli bombardati che ricordano molto Israele, la Palestina e le altre popolazioni vessate. Si usano parole come “mutanti”, “cyborg” o altro per non focalizzarsi tanto su tematiche di palestinesi o ucraini, quanto per evidenziare la problematica attuale che regolarmente abbiamo popolazioni da annientare o guerre.
Da “Metropolis” ad altre contaminazioni prestate dal cinema e dall’animazione, come “Blade runner”, “Guerre stellari” o l’”Uomo tigre” e poi “Conan” di Miyazaki: è anche un omaggio ai grandi maestri che hanno segnato un’epoca?
Certamente, ma nel momento in cui lavori sul cyberpunk è facile raccontare un visionario simile. La fantascienza ha i soliti paradigmi della pioggia e dell’immaginario decadente. Da “Total Recall” a “Blade Runner” e al coreano “Natural City” lo schema è lo stesso: grattacieli o pioggia raccontano un visionario che si somiglia. Che però fa parte di quello stesso mondo letterario.
Secondo il Grande Cervello è necessario «preservare la vita per avere il diritto di creare la morte». Una riflessione sull’inquietante facilità con cui si manipola il codice genetico e ci si abbandona all’intelligenza artificiale?
Il Grande Cervello è una divinità che nel film non si vede mai, deve cannibalizzare gli schiavi, ma è un elemento necessario, di cui gli stessi cittadini di Sendai City hanno bisogno. Per avere una divinità senza la quale non potrebbero vivere.
La solitudine di Alan Sheen – che per tenere in vita la moglie è costretto a uccidere – evidenzia le contraddizioni di una società che contrappone potenti e inermi. Vince sempre il più forte?
Ciò che preme affrontare non è tanto il vincere o il perdere, quanto il concetto di divinità e realtà, che è percepita dai tre punti di vista. La verità di Sendai City è spezzata in tre parti, perché ciascuno dei personaggi ha le proprie motivazioni. Non c’è chi è sconfitto e chi no, tutti hanno portato a compimento il necessario per raggiungere una propria verità.
In quest’eterna lotta tra bene e male, a risvegliarsi dal suo lungo sonno è Syan, che resiste alla cibernizzazione e al fantoccio di democrazia, per poi contribuire alla scia di sangue…Un cul de sac?
La cibernizzazione è la metafora dell’era contemporanea, in cui siamo controllati e spiati attraverso cellulari o computer. La società raccontata è quella di una multinazionale divenuta così potente da creare una megalopoli di cui controlla gli abitanti attraverso un chip inserito. L’intenzione è sottolineare il controllo, e l’impedimento di avere una propria posizione. La volontà è denunciare il controllo totale, come nel libro di Orwell “1984”, dove la polizia psichica controlla anche i tuoi pensieri.
«La verità è uno scherzo bizzarro»: nel senso che l’umanità tende inutilmente alla ricerca del vero che continuamente sfugge?
Il punto è che la verità non sarà mai completa, perché man mano che aumenti la conoscenza devi rivedere la verità. Non avrai mai la verità assoluta. Lo vediamo nelle indagini, nella Storia, in cui spesso si scopre un elemento nuovo che porta a rivedere i fatti. Cerchiamo una vertà assoluta, ma non la potremo mai avere. Dobbiamo aprirci noi stessi a un immaginario di cambiamento, perché saremo sempre in cammino.
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.




Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione