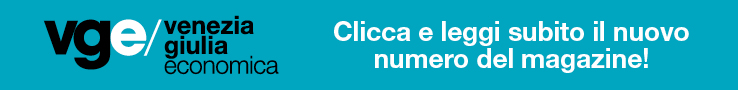Il racconto
San Nicolò e il legame con il territorio: l'hospitale di Ruda
_675319708ac68.jpg)
Ferruccio Tassin ci narra del santo vescovo di Myra e noto in tutto in Occidente e Oriente.
Abbiamo la sagra delle scienze ausiliarie della storia con questo scampolo di leggenda raccolto a Ruda: la demologia, che si incontra con la toponomastica, e la topografia storica. A San Nicolò, si racconta, c’era un luogo dove si raccoglievano i cavalieri che andavano in Terra Santa a liberare il sepolcro di Cristo, e per la strada di Levata, all’incrocio con l’Armetaressa e la Cortona, Rosina, una fanciulla, rastrellava l’erba e si incontrava con un cavaliere. Lui deve partire per terre lontane. Lo aspetta; ritorna, si sposano alla solenne: principe e cavalieri, con stendardi armi e cavalli, e popolo. Il principe regala agli sposi una casa a San Nicolò e, per ricordo pianta una croce, donde località Crosada; saranno sepolti vicino, “Rosuta” e il cavaliere, insieme con un tesoro trovato alla Cortona. Senza volare di fantasia: troviamo Cortona, possibile da curtis - per San Nicolò - e casaforte verso l’Isonzo; il pericolo dell’acqua; la strada di levata per quello; via per l’oriente; pellegrinaggi e crociate; incrocio, e la toponomastica ci soccorre con la strada di Jevada (questa, perché ce ne sono altre), che si incontrava poi a Perteole con La Strada Granda di Sant’Andrea, e ancora più avanti con la Levata di Cavenzano verso i guadi (Puntin).
Non sappiamo di storici amori così, ma un Patriarca era andato alla crociata in Terrasanta; i cavalieri erano a San Nicolò, e la strada era determinante. Il sigillo di qualità alla leggenda ci viene dai documenti (Luigi Gratton): 1249, 16 dicembre “Nos”; il noi maiestatico ci spalanca subito qualcosa di grande; il lui plurale è un bavarese, zio di Santa Elisabetta di Ungheria, creato patriarca da Onorio III nel 1218, Bertoldo di Andechts, che vara il documento due anni prima dell’appello all’eternità (1251). Non solo, ci chiarisce subito che il merito della fondazione è del suo predecessore, grande anche lui (ma, ahinoi, ambedue sono guerrieri!), Wolfger von Ellenbrechtskirchen o di Erla, vescovo di Passau, patriarca dal 1204 al 1218, protettore di poeti come Walter von der Vogelweide e il più nostrano Tomasino di Zercläre. Se non è lui il principe della leggenda, è certo lui che andò alla crociata, ed è lui che ha fondato lo xenodochio a San Nicolò, fra il 1204 e il 1211, visto che in quest’anno già è documentato.
Ed è sicuro che la sua vita, quella dell’ospizio, inizia da lì: “hospitale novum”, lo dice Bertoldo.
Poi giù un documento del basso Medioevo, che alcuni vorrebbero ideale, e altri, sempre sbagliando, vorrebbero sempre arcigno e arretrato, giù un documento di quelli che farebbero la felicità di uno storico medievista, di un esperto di paleografia e diplomatica, di uno storico del medioevo europeo e nostrano; di uno studioso del paesaggio o di un esperto del diritto medievale. Vi nuoterebbero come pesci nell’acqua, frotte di studenti di storia medievale, assatanati di nuove esperienze nel campo. Eh sì, faremo soltanto alcuni esempi.
Primo: l’ospedale è accanto alla strada di Aquileia e l’ha resa migliore; per garantire l’ospedale, che dovrà provvedere anche alla strada, “in perpetuum” (e qui si respira onnipotenza ed eternità); Bertoldo lo dota con la chiesa di Camarcio e 6 mansi, con le pertinenze, dove si capisce che c’è terreno bonificato e non, e fissa i confini in lunghezza e larghezza (con preziose notizie). Racconta, il testo, che al tempo della donazione c’erano paludi deserte di gente; e pericoli; chi ci metteva piede “periclitava” fra ladroni e ostilità dell’ambiente. L’ospedale è lì per fugare pericoli, assistere passeggeri; mantenere la strada, mediante uomini di provata fede, tanto religiosi che laici, ed ecco i Giovanniti (nel documento scappa anche un ospedale Sancti Johannis). E vien stabilito quando e quanto intervenire a spese dirette dell’ospizio e quanto da altri. Si prospettano future donazioni di benefattori, che, unite alle rendite, potevano provvedere a soccorrere prigionieri e pellegrini ultramarini, in Oriente, nei luoghi santi, con un accordo che si era stipulato perfino coi Saraceni. Grandioso che si avesse la capacità diplomatica di trattare con loro e interagire con luoghi che rispondevano a Gerusalemme, Aleppo, Damasco (di nuovo storia contemporanea…). L’assistenza si spalanca ad ampio raggio come i cerchi nell’acqua!
Chiarisce, Bertoldo, che il predecessore ha concesso (sempre col consenso dei canonici, dei vassalli e dei ministeriali) le decime dei novali (campi nuovi messi a coltura); però, in obbligo di soggezione alla Chiesa Aquileiese, l’ospedale doveva corrispondere alla luminaria un’orna di olio e una libbra di incenso, e che, more antiquo, quelli di Camarcio fossero battezzati solennemente nella chiesa di Aquileia. Diede, inoltre, alla morte del preposito di San Felice in Aquileia, la chiesa di San Michele tra Sacile e Caneva e la villa di Blasiz; poi, a conto di permuta con questa villa, il rettore dell’ospedale ricevette due mansi ad Aiello, 2 a Bicinicco e terre con un mulino a Campolongo e giù un altro obbligo: quota di denaro per riparare, ridonare o fornire i sacri vasi della Basilica. Ma il cruccio dell’estensore del documento era sempre quello di sovvenire alle necessità dei prigionieri d’oltremare e, se non si fosse potuto soddisfare a un tanto, si doveva mantenere altri poveri, qui nello xenodochio. Non manca l’anatema conclusivo e riassuntivo, in caso di inottemperanza alle disposizioni di Bertoldo e del Predecessore… Fin nelle sottoscrizioni dei testimoni, si vede l’ampiezza e la grandezza e la solennità di questa Chiesa Aquileiese: ci sono fra gli altri i vescovi di Parenzo e di Lubiana, insieme a un nugolo di nobili e dignitari della corte patriarcale.
In base a questo, l’ospedale di San Nicolò (poi assunse il nome del Santo) era riferimento a vie del nord, dell’est di respiri mediterranei. Già contribuiva alla vita della Chiesa Aquileiese, l’ospedale, come recitano documenti successivi, ma nel tempo l’importanza andò scemando per il disseccarsi della vitalità in quella via verso l’Oriente. Così i beni passarono in Commenda (ampiamente trattata da Gratton) sino alla fine in età napoleonica. Rimangono ora la Commenda, edifici disfatti dall’incuria che rientrano nel popoloso capitolo dell’agonia della Bassa (piste ciclabili…), un tempo guardava la via verso i guadi a est; l’ospedale ancora superbamente integro, ma dal problematico futuro (attuale edizione del Cinquecento-Seicento); la chiesa largamente rimaneggiata nei secoli, con tracce romane e dentro tanto San Nicolò. San Nicolò, appunto, raffigurato con le vesti episcopali, con l’omophorion, stola decorata dei vescovi orientali, o con le vesti episcopali più classiche (nella chiesa di an Nicolò c’è una sintesi) e 3 mele doro in mano o su di un piatto.
Di Lui c’è una storia leggendaria (IX sec. S: Metodio); è patrono di Grecia, Russia e Bari. Nato a Patara, in Licia, intorno al 255 d. C., diviene vescovo di Myra capitale della Licia. Non era come gli altri vescovi del tempo, un teologo, , ma pratico, pastorale. Di lui non si sa molto. Avrebbe partecipato, in funzione antiariana il Concilio di Nicea (325), che, è interessante rilevare, stabiliva in uno dei canoni, la fondazione di uno xenodochio in ogni diocesi. Leggende fioriscono nella sua organica carità: salva 3 fanciulle dalla prostituzione (3 mele d’oro, o palle, o sacchetti); 3 marinai dalla morte; 3 condannati ingiustamente. Visse l’era di Costantino (Elena ospedali), + 334 e Costantino 337. Nel 1087 due sacerdoti di Bari, Lupo e Grimoaldo, lo portano in città e nel 1095 Papa Urbano II in un concilio a Bari consacra la chiesa. L’arte lo rappresenta a Roma (VII sec.), a Santa Sofia, Istambul, X sec.; Venezia e Monreale XII sec. Santo già dalla fanciullezza (Leggenda aurea di Jacopo da Varazze), il mercoledì e il venerdì, nei tempi di digiuno, non si allattava. In Germania lo portò Teofane (reggente per Ottone II), quindi dopo il 972. Lo ricorda Dante nel Purgatorio (canto XX): “Larghezza che fece Nicolò alle pulcelle/ per condurre ad onor lor giovinezza”. Patrono di pellegrini, barcaioli, marinai, ma soprattutto della carità. Nella visione attuale, spesso economicistica della sanità, pur nel mutare dei tempi, si può partire dalla parabola del buon Samaritano. Gesù replica (Luca, X) al dottore della legge che aveva risposto alla domanda di chi è il suo prossimo: “Vade et tu fac similiter”; nasce di lì il perché dello xenodochio di San Nicolò! Una risposta in cui si dovrebbe riconoscere un dovere!
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione