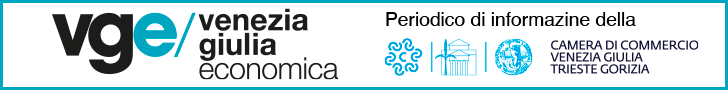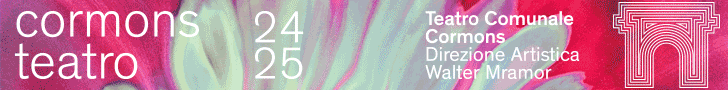la serata
La malattia mentale fra parentesi grazie al lavoro, il film su Basaglia a Gorizia

Ieri sera la proiezione al Kinemax del film di Erika Rossi, raccontando l'esperienza all'Opp di Trieste a inizio anni Settanta. Le voci di chi ci ha lavorato.
Chi non ha, non è. Chi ha perso tutto non conta più nulla, nella società. Questo è il credo di Franco Basaglia che lo condusse ad aprire i manicomi. Liberando i degenti affinché venissero accolti in seno alla comunità, per strapparli a quelle tenebre di isolamento ancora oggi diffuso nel resto del mondo. È stato proiettato ieri sera – presso una gremita sala del Kinemax di piazza Vittoria a Gorizia – il documentario “50 anni di Clu-Lavoratori uniti Franco Basaglia Cooperativa sociale” firmato da Erika Rossi.
Una battaglia «difficile, ma vinta», come ha ribadito l'ex direttore del Centro di salute mentale goriziano Franco Perazza, intervenuto alla serata. Il quale citando Norberto Bobbio ha rimarcato come quella basagliana fosse stata «l’unica rivoluzione completata», che ha trasformato i pazienti in «degenti volontari». Addio ai chiavistelli, ai muri, ai letti di contenzione. In Italia non vi sono più le «sbarre alle finestre» o la «puzza di piscio ovunque» che riportava Alda Merini nei suoi versi, dopo aver vissuto sulla propria pelle l’internamento.
Grazie a Basaglia, dagli anni Settanta non si odono più nemmeno le urla per le torture dell’elettroshock, che annientavano l’umanità piuttosto che innalzarla dalle sue ceneri. «L’altra operazione fu costruire i centri di salute mentale, e la terza fu inventare le cooperative sociali grazie alla collaborazione della comunità slovena che già ci lavorava prima di Basaglia», ricorda ancora Perazza alludendo a Danilo Sedmak. Prima dell’arrivo dei due medici, l’Opp di Trieste era dominato da quella che veniva definita “ergoterapia”. Su 1200 degenti, quasi 500 erano impiegati come giardinieri, cuochi e nelle pulizie.
«A nessuno veniva in mente che il lavoro che svolgevano i degenti in nome della famosa ergoterapia altro non era che sfruttamento», scriveva Sedmak in occasione dei 40 anni della Clu. Con la nascita della cooperativa si invera il principio di collocare la malattia mentale «fra parentesi», essendo evidente come «non bisogna guardare la persona malata, ma incontrarla, valorizzandone la soggettività e rendendola una risorsa», ha ribadito Perazza. Da una panoramica su Trieste, con la marea di case distese sull’orlo dell’immensità azzurra, la macchina da presa scende al parco di San Giovanni, dove Massimo Cirri passeggia per incontrare i soci della cooperativa e dare voce alle loro mille storie diverse.
«Io di mestiere faccio la radio ma anche lo psicologo – avvisa la voce narrante di Cirri – Questa è una storia che ne contiene molte altre. Qui nasce la prima cooperativa sociale al mondo». All’apparenza non c’è nesso, fra salute mentale e lavoro. «Cosa c’entra il lavoro con il manicomio?», domanda retoricamente Cirri. Il primo giugno del 1971 Franco Basaglia e sua moglie Franca Ongaro fanno il loro ingresso all’ospedale di Trieste. Sceglieranno di reclutare giovani laureandi «perché volevano persone non contaminate dalla psichiatria», spiega Giovanna Del Giudice, storica collaboratrice di Basaglia.
Le attività dei degenti venivano ricompensate con una “moneta speciale”, rammenta lo psichiatra Franco Rotelli, scomparso lo scorso anno. Fu l’allora Michele Zanetti - presidente della Provincia dal 1970 al 1977 – a chiamare Basaglia per dirigere l’ospedale psichiatrico. «C’era un problema enorme – racconta Rotelli – i pazienti lavoratori non avevano diritti civili. All’epoca i malati di mente erano privi di diritti civili e politici». L’unica “moneta” data ai malati era una sorta di «bitcoin», commenta Zanetti. Persone private dei propri diritti, sfruttate e non retribuite. Di qui la spinta al riconoscimento di un lavoro reale, ma «il tribunale non ne voleva sapere e si bloccò tutto».
I pazienti presero a rivendicare il proprio diritto fondamentale e inalienabile e in un primo momento si stabilì una tacita alleanza fra infermieri e pazienti. Finché il consiglio provinciale decise di approvare la delibera per costituire la cooperativa di lavoratori. La quale sancì la fine dell’ergoterapia e l’inizio della libertà. Questo perché «non fosse spacciata per terapia la schiavizzazione fatta ai malati», e perché solo il lavoro – quello retribuito – restituisce dignità alla persona. «Nella nostra vita il lavoro è tante cose – riflette Cirri nel documentario - ma quando il lavoro manca ci sentiamo persi».
Zaino in spalla, Cirri incontra i soci lavoratori. Coloro che, pur pur non essendo malati, rimarrebbero emarginati senza un mestiere che gli conceda di vivere. Incontriamo Luis Carlos Candelo, che lavora in mensa e ha comprato casa, o il socio lavoratore Franco Zanin, che ramazza intorno all’ospedale Maggiore e dal carcere ha trovato impiego grazie alla cooperativa. Oppure Gioia Poffo, un’altra socia lavoratrice che grazie alla Clu riesce a portare a termine gli studi e a ottenere un contratto di lavoro. «La Clu nasce faticosamente fra il 1972 e il 1973 e fino al 1980 rimane un caso unico», sottolinea Gigi Bettoli, alludendo a un’impresa che oggi dà lavoro a più di 300 persone.
L’idea diventa vincente quando il lavoratore uscirà dalle mura dell’ospedale, confrontandosi finalmente con gli altri. Particolare spinta all’emancipazione femminile verrà data dalla prima presidente Claudia Rolando, portatrice di una visione imprenditoriale più sottile e «cuore della cooperativa sociale».
A conclusione della proiezione la regista ha incontrato il pubblico, rispondendo alle domande moderate dalla critica cinematografica Eleonora Degrassi. «Gli internati che firmarono quel primo verbale sono morti, come lo è Danilo Sedmak, infermiere e psicologo che volle la costituzione della cooperativa – racconta Rossi – Massimo Cirri lavora a Radio 2 come conduttore di “Caterpillar”. Nel documentario si relaziona in maniera semplice, con i soci». Dolore e sofferenza alleggerite dalla musica dei Maxmaber Orkestar, a sottolineare lo spirito di confine del territorio in cui le storie si svolgono.
Un film portato al Trieste film festival e a Roma l’undici marzo scorso, che sbarcherà venerdì presso la cineteca di Bologna, oltre che a Venezia in occasione del Festival dei matti. «Le persone messe in scena non provengono tutte da difficoltà mentali, ma anche dalle difficoltà della vita – ha spiegato Rossi - Con loro ho visto una comunità. E ho ritenuto importante restituire questo pensiero corale».
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram e Whatsapp, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione