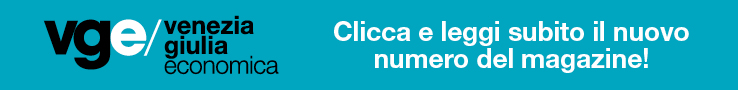LA LETTURA
Grado, in scena 'El critoleo del corpo fracassao' nel ricordo dell'amicizia tra Marin e Pasolini

Le letture sceniche delle “Litànie” sono state riproposte nella Basilica delle Grazie, corollario a memoria del poeta gradese per i quarant’anni dalla sua scomparsa e il cinquantenario dell’uccisione dello scrittore friulano.
Spinte dalla risacca sull’arenile, luccicano nella sorprendente perfezione del guscio calcareo, finché il piede non le calpesta. In dialetto graisan il crepitio delle conchiglie frantumate viene reso dal termine “critoleo”, restituendo con l’asperità del termine l’amarezza per la meraviglia perduta. È andato in scena nella serata di martedì 19 agosto - nella sacralità raccolta della basilica di Santa Maria delle Grazie a Grado - lo spettacolo su lettura del poemetto “El critoleo del corpo fracassao” di Biagio Marin, anticipato da frammenti del suo stesso diario. «La composizione – rimarca l’assessore alla Cultura Lidianna Degrassi - esprime tutto il dolore possibile verso una morte tanto ingiusta e disumana». Un corollario a memoria del poeta gradese per i quarant’anni dalla sua scomparsa, coincidente con il cinquantenario dell’uccisione di Pierpaolo Pasolini cui le “litànie” furono dedicate. «Sono componimenti in tono sacrale», spiega Ivan Crico, che nel 2021 ha curato e tradotto l’opera per Quodlibet incastonando preziosi frammenti dai diari inediti, estratti dallo studioso Pericle Camuffo.
«Possiamo considerarli – prosegue - una sorta di stazioni attraverso cui ripercorre i momenti cruciali e il pensiero di Pasolini. L’opera somiglia a quei componimenti sacri medievali scritti da Jacopone da Todi. È caratterizzata da un ritmo saturo di pathos e lirismo in cui si alternano momenti di angoscia, commozione e strazio interiore». Accompagnate dalle sinfonie di Bach suonate al violino da Enriketa Cefa, le letture sceniche di Tullio Svettini hanno tramutato la prosa dei diari e le tredici sequenze di quartine in preghiere accorata, luminose filigrane levitate fra mosaici e navate come nenie antiche.
La scena si apre a Casarsa con la lirica “Aga dal me pais”, per poi spostarsi a Grado nel «covo de corcali» di “Paese mio”, e infine introdurre la «triste vicenda» affrontata nei diari. È un martedì 4 novembre del ’75 quando Biagio annota «Il mio tempo è passato, e anche quello di Montale e di Pasolini, ma né l’uno né l’altro passeranno». Dalle riflessioni sui funerali - ai quali mancano le autorità e persino il presidente della Filologica friulana – alle considerazioni sul genio scomparso e sulla vita che continua, Marin pone l’accento su «ciò che Pasolini ha creato», che nonostante tutto «continua a esistere». Ed ecco la lettura del poemetto, mentre l’abside s’illumina del colore della passione. «In poche pagine – chiosa Crico – l’autore racconta il suo rapporto con Pasolini fissando le luci e le ombre di questo grande poeta. Un momento di grande felicità espressiva, pur nella tragedia dell’uccisione». Perché il canto solitario del «rusignol» di leopardiana memoria s’interseca alla morte «nel deserto d’un prào», sopraggiunta per investimento con l’inaudito scricchiolio delle ossa, infrante come gusci vuoti di conchiglie.
«Marin lo definisce “un rosario” per Pasolini – interviene a margine Svettini – e lo scrisse immediatamente dopo la morte dell’amico. Conobbi il regista di “Medea” mentre girava il film nella laguna di Grado, insieme a Maria Callas. Ebbi modo d’incontrarlo al cinema Cristallo, durante un’orazione dedicata a Marin, che io stesso misi in scena anni fa. Ma lo incontrai anche durante le sue prime cinematografiche, in quanto fin dagli anni Cinquanta aveva creato un sodalizio con Marin. Ne abbiamo ampia descrizione in varie pubblicazioni, e soprattutto nel carteggio epistolare tra i due. Il nostro poeta divenne famoso grazie alla conoscenza con Pasolini». Fu l’amicizia con il regista, poeta e scrittore friulano a condurre “Biaseto” oltre la cerchia dell’isola di Grado, portandolo ad approdare sulla terraferma e nel resto del mondo. «Pasolini – aggiunge - amava i dialettali, le cose locali. Nell’orazione a lui dedicata si toccano temi diversi, compreso quello della pederastia», che traspare «tra vogie sante e brame impure». «Due anni fa – rammenta - con la regia di Francesco Accomando mettemmo in scena “Fratelli d’acqua”, a ripercorrere il sodalizio anche con il linguaggio di Casarsa di non immediata comprensione». Un’amicizia grande che diede i natali alle celebri Giornate del Cinema muto, interrotte nel 1975 e infine approdate a Pordenone.
«Per Grado – ammette - fu un periodo felice: qui Pasolini presentò in anteprima “Porcile”, “Il Decameron” e “I racconti di Canterbury”, mentre suo cugino Nico Naldini mostrò in retrospettiva “Fascista”, tratto dai filmati d’epoca presentati fuori concorso. Tutto questo rientrava nella Settimana del Cinema muto, in cui la celebre Francesca Bertini presenziò per la proiezione di “Assunta spina” e “Cabiria” di Giovanni Pastrone. Dopo la sua morte fu Pordenone a prendere le redini, ma le Giornate del Cinema Muto sorsero qui a Grado tra il ’69 e il ’73». Un progetto cinematografico sostenuto da Pasolini e dal pittore Zigaina suo grande amico, che lo condusse sull’isola per le scene di “Medea”. «In quell’occasione – precisa - il Comune diede in concessione a Pasolini la piccola isoletta di Mota Safon, ora gestita dall’associazione Graisani de Palù». Su quell’isola ai margini della laguna lo scrittore e regista amava rifugiarsi per leggere o dipingere. «Qui sorge un piccolo museo – specifica Svettini – che ricorda la presenza dell’artista, il quale si divertiva a dipingere con elementi naturali realizzando quadri con conchiglie o sabbia. Venne fatta anche un’esposizione all’Hotel Argentina, dove in genere soggiornava durante la Settimana del cinema».
Una parentesi dorata che tramutò Grado in centro culturale dove confluivano poeti, letterati e intellettuali calamitati da proiezioni e conferenze. «In quel periodo Pasolini contestava la Mostra del cinema di Venezia – chiarisce - così scelse Grado al posto del Lido». Inevitabile per Svettini una riflessione sull’odierno impoverimento delle sale cinematografiche gradesi. «Allora d’estate avevamo cinque cinema all’aperto, oggi nemmeno uno. Il cinema Cristallo, che è chiuso da molti anni e andrebbe ristrutturato, era la sala in cui si svolgeva la rassegna, allora molto seguita». Votato al teatro fin dal lontano 1958 con Ruzante, Andrea Calmo e Goldoni, negli ultimi anni Tullio Svettini ha riproposto una trilogia sugli antichi mestieri del nostro territorio con “Le anciughere”, “Le tabacchine” e “Le mondine”. La trilogia - nella prossima stagione di prosa arricchita con “Le bagnine” - di certo avrebbe attratto l’interesse dell’anima «nobile e fine» di Pasolini, che amò il Friuli come «spirito d’amore che al suo paese torna di lontano».
«Un tempo – sottolinea il direttore artistico - le bagnine erano custodi della spiaggia. Invece le “anciughere” lavoravano nella fabbrica del pesce, che durante l’Impero asburgico erano cinque o sei. Poi c’erano le tabacchine impiegate ad Aquileia, dove sorgeva l’essiccatoio del tabacco, e le mondine impiegate nella campagna di Fossalon per togliere il sale dalla terra. Furono loro a piantare il riso». Un Friuli «de la tera distesa» come nei versi dei due poeti, dove la bellezza delle montagne si moltiplica nella quiete delle onde che abbracciano l’Isola del Sole. Quel «Friuli beato, de fiumi e de roge» ancora si rispecchia nelle loro opere, cristallizzato contro lo schianto del tempo nella terra arata o nei sognanti bastimenti all’orizzonte.
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.
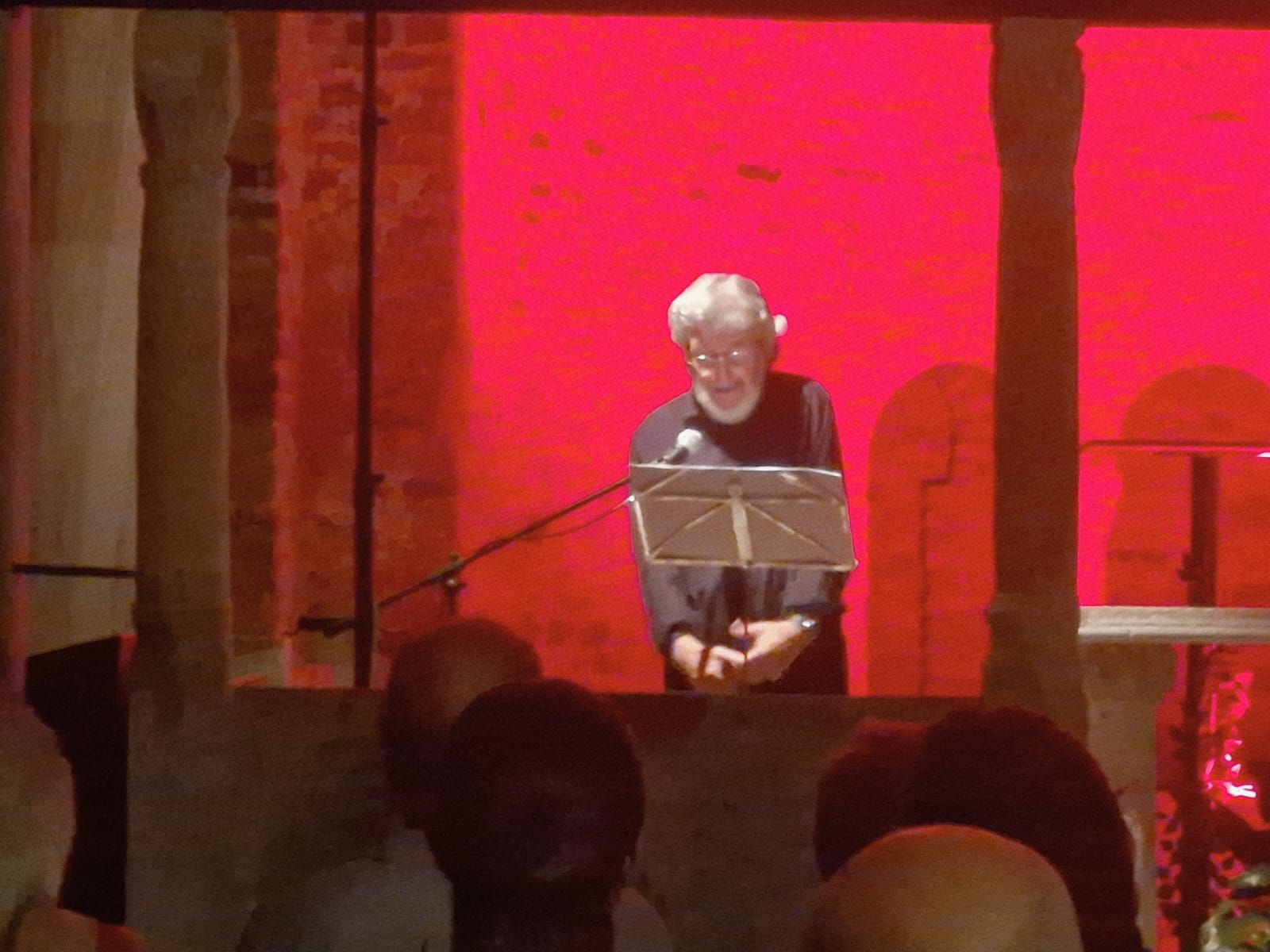




Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione