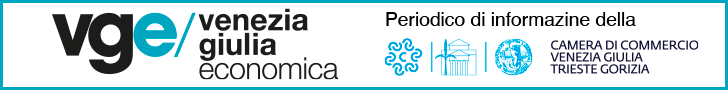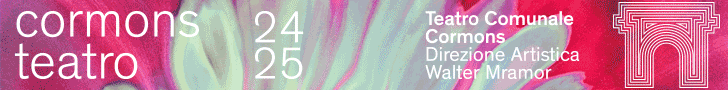a gorizia
La famiglia di Norma Cossetto a èStoria, «adesione al fascismo no violenta»

Il sogno della giovane era diventare una geografa, il ricordo della famiglia: «Accanimento con scopo di dominazione totale».
Si è svolto nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio, presso la Mediateca Ugo Casiraghi, l’incontro per ricordare Norma Cossetto, dove Patrizia Lucchi Vedaldi ha presentato il suo saggio dal titolo “Norma Cossetto studentessa istriana caduta per la libertà”. Presenti in sala anche alcuni membri della famiglia Cossetto, fra cui Dino il figlio di Giuseppe, che ha acceso un dibattito su alcune date: “Quello che non ci torna come parenti è il 2 ottobre, perché il mio papà è andato con Licia in prigione a Parenzo. Al ritorno sono stati attaccati da una pattuglia di tedeschi”. A questo la Vedaldi ha voluto ribattere come il suo sia uno studio di ricerca “basato sui dati, non sulla memoria”.
La studiosa, nata a Venezia ma originaria di Lussino, ha voluto ricordare un’immagine inedita della giovane “che nel ‘43 girava in bicicletta e faceva domande scomode”, con il sogno di diventare geografa. “Nella cattedra di geografia per gli studenti di Lettere veniva approfondito l’aspetto economico, storico, antropologico. Norma girava per i villaggi secondo le direttive del professor Lorenzi”, i cui “punti sono gli stessi del Memorandum di Alcide De Gasperi, che sosteneva l’italianità dell’Istria”. L’immagine che ne emerge è quella di una donna appassionata ai propri studi, che aveva compiuto una scelta “coraggiosa, perché grazie alla riforma Gentile non era possibile insegnare in tutti gli istituti e i posti dovevano essere riservati agli uomini”.
Studentessa che intendeva diventare geografa, “ruolo che in Italia verrà ricoperto da una donna solo nel 1968”. Con questo saggio, dunque, la Vedaldi intende rendere giustizia a una figura tanto manipolata dalle correnti politiche, quanto poco considerata per gli studi universitari e la passione per l’insegnamento: “N'è stato fatto un puzzle per creare una biografia ad hoc”. L’autrice ricorda poi i versi dello scrittore Marino Varini: “Rossa è la terra istriana, che s'ingemma a specchio del mare - da Pola a Capodistria - d'Orsera e di Rovigno, di Parenzo e di Pirano: ma non di bauxite soltanto - è rossa anche di sangue”, si legge nel romanzo “Terra rossa”.
Alludendo all’anarchia in cui il territorio istriano era precipitato dopo la caduta di Mussolini, ma anche alla tesi di laurea di Norma, che stava approfondendo le ricerche con il professor D’Ambrosi, “esperto geologo che le dedica una poesia”. Una donna solare, piena di ottimismo e ormai prossima alla laurea, che fu concessa ad honorem l’8 maggio 1949. La Lucchi Vedaldi iniziò ad approfondire gli studi sulla martire istriana in concomitanza di alcune manifestazioni contrarie alla commemorazione di una fascista. “In quel periodo la gran massa degli italiani era genericamente fascista, e l’unico dato che abbiamo è la sua iscrizione al guf di Pola".
"Poi molte ragazze partecipavano alle manifestazioni per incontrarsi con i ragazzi”. Del resto, molti intellettuali italiani avevano aderito al fascismo, da Pirandello a Malaparte, da Pavese - poi mandato al confino con l’accusa opposta - al grande Ungaretti. Che tipo di fascismo era, il loro? Si trattava di un’adesione priva dei connotati violenti caratteristici delle estreme destre. La stessa sfumata ideologia cui aderì Norma: “Alla domanda: perché si diventa fascisti in casa Cossetto?, la risposta più probabile è per adesione a una causa di italianità che poteva voler dire difesa della terra, delle proprietà e più in generale delle tradizioni nazionalistiche, contro i moti autonomistici delle minoranze slave”.
Così Frediano Sessi nella biografia “Foibe rosse – Vita di Norma Cossetto”. Una devozione che diviene nel suo solipsismo un mitizzare la “buona terra” in cui era nata. Certa che il suo ex-studente, quello che la condusse in caserma con la motocicletta, non avrebbe potuto usarle alcuna violenza. Né lo avrebbero fatto i braccianti impiegati nelle proprietà dei Cossetto, poi passate agli slavi insorti, da lei percepiti come appartenenti alla stessa “grande famiglia” del paese. Per Norma era impossibile rinnegare quell’ordine costituito a cui apparteneva, o l’amore per la propria famiglia.
Frediano Sessi immagina di scrivere il diario degli ultimi giorni di Norma, dove si legge: “Io e mia sorella Licia, fin da bambine, abbiamo trascorso il periodo scolastico a Gorizia, nel collegio delle suore di Nostra Signora. Si tornava a Santa Domenica di Visinada a Natale, Pasqua e per le vacanze”. Riusciamo a vederla, Norma, mentre cammina lungo le stanze in penombra in Via Santa Chiara, oggi adibite a palestre. Attraverso i nostri occhi rivive quel giardino nascosto dove gioca con la sorella, che si affaccia sulla sottostante Via Brass. Il cielo e le nuvole che Norma dipingeva nei suoi quadri sono le stesse che mutano in miriadi di forme diverse; si addensano, lasciano cadere la pioggia per poi diradarsi a lasciar passare l’arcobaleno.
Una purezza d’animo, la sua, che stride con “la deriva morale” dalla quale stava per essere inghiottita. “Norma poteva essere il simbolo supremo di tutti i nemici possibili: fascista, emancipata, ricca, bella e intelligente”, prosegue Sessi, e in questo senso doveva essere annientata. Si ritrovò all’alba sul ciglio della voragine di Villa Surani, le mani legate da un filo di ferro, i pensieri ormai in delirio per la sete e le terribili sevizie subite nei giorni precedenti. “Qualcuno si incaricò di pugnalarla al seno e ficcarle un legno appuntito”, prima di spingerla nella foiba.
“Su di lei l’accanimento assume uno scopo di dominazione totale, volto a spogliare d’ogni forma di umanità la comunità a cui appartiene”, conclude Sessi riferendosi ai partigiani titini. “C’è un tempo per vivere e un tempo per morire. E tra i due, c’è il tempo per ricordare”, dice la Allende nel suo romanzo “Violeta”, riprendendo le Sacre scritture. Viviamo in un tempo di instabilità e guerra, astuzie e giochi incomprensibili dei potenti contro civili inermi. Un tempo, il nostro, in cui Norma assurge a simbolo di tutte le atroci vicende della guerra, dove la memoria che trascolora deve ritrovare spazio in ciascun individuo, affinché si possa tornare a dipingere il mondo del colore della pace.
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione