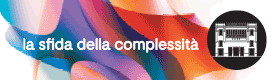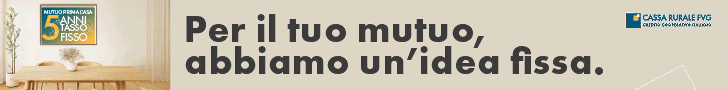LA CONFERENZA
L’Europa e quella mappa «che non sta mai ferma»: la lezione dello storico David Reynolds a Gorizia

Il docente dell’Università di Cambridge ospite al polo universitario di Santa Chiara per il primo incontro della terza edizione del forum internazionale ‘Città divise e città contese negli anni della Guerra Fredda’.
Secondo conflitto mondiale, il poeta americano Carl Sandburg così s’interroga: «Perché la mappa dell’Europa non sta mai ferma?». Una citazione fatta propria da David Reynolds, docente di Storia all’Università di Cambridge e ospite giovedì venti marzo al primo incontro del Forum Internazionale “Città divise e città contese negli anni della Guerra Fredda”.
«Come istituzione abbiamo l’obbligo di favorire incontri fra studiosi per stimolare un’analisi storica», ha rimarcato il rettore dell’Università di Udine Roberto Pinton, che ha aperto l’incontro nel polo di Via Santa Chiara a Gorizia. «Con il sindaco Ziberna e il presidente della Carigo Bergamin abbiamo stipulato un sodalizio – prosegue – per far sì che queste attività diventino tradizione e appuntamento fisso, esperienza da trasmettere agli altri».
Con grande emozione il primo cittadino Ziberna ha evidenziato come Gorizia e Nova Gorica non siano città vicine, «ma un’unica città divisa dal trattato di Parigi», che arbitrariamente separò col filo spinato orti, case e tombe. Due città che secondo il sindaco possano testimoniare «in Europa e nel mondo come si possa andare avanti», passando oltre il proprio dolore. «Se non lo faremo, saremo responsabili di quest’incapacità di scrivere nuove pagine di Storia». Parole che s’intersecano con i confini più ampi che vanno disegnandosi in Ucraina, costretta a cedere i suoi territori nel cuore della stessa Europa. Terre contese fra uno “zar” che detta condizioni a suo unico vantaggio e un Trump che mira a depredare prima che a stipulare una pace, attaccando duramente Zelensky nello Studio Ovale.
«Dall’intervento del sindaco avete compreso quanto sia ancora viva la vicenda di Gorizia “divisa e contesa” – osserva Bergamin – così che dopo 80 anni siamo ancora in preda a sentimenti forti. Una responsabilità nei confronti dell’Europa, che deve spingerci a testimoniare come da una realtà così difficile si possa approdare a un progetto culturale». E nel leggere la testimonianza racchiusa nella lettera che il 20 maggio del 1966 Ungaretti scrisse all’allora sindaco Michele Martina, sottolinea il parallelismo con l’attuale volontà di rinascita. «Gorizia non era il nome d’una vittoria – legge - ma di una comune sofferenza, la nostra e quella di chi ci stava di fronte e che dicevamo nemico», che per Ungaretti era la «parola tremante nella notte». Uniti in questa comune fratellanza, «sono convinto che a questo spirito attuale abbia contribuito anche Ungaretti», conclude Bergamin.
Lieto di ritrovarsi in una città «affascinante ed elegante, oltre che amichevole», Reynolds ha invece raccontato la Storia attraverso una lente diversa. «Forse stiamo di nuovo assistendo alla creazione di un mondo d’imperi», riflette. «”Perché la mappa del mondo non sta mai ferma?” Perché ogni volta che la mappa si sposta le persone soffrono». A partire dai confini spazzati via dalla Prima Guerra mondiale, fino a quelli polverizzati dell’odierna Ucraina, in cui i soldati vanno a morire per offrire un futuro di libertà ai propri figli.
«L’implosione di grandi poteri egemonici al vertice per centinaia d’anni, come gli Hohenzollern o gli Asburgo, favorisce gli altri Stati – ribadisce - sorti dalle ceneri di quest’Imperi. La geografia ha un costo». Quello di milioni di vite umane, che con il proprio sacrificio hanno contribuito a creare le mappe attuali. San Michele e Redipuglia restano a monito delle disfatte italiane, ma la scia di sangue si allunga fino a Hitler che invade l’Unione Sovietica e quindi al Giappone, il quale dopo l’attacco di Pearl Harbor del ’42 ne organizza di altrettanto feroci. Le mappe che narrano la fine del Terzo Reich, in cui gli eserciti alleati circondano la Germania nazista partendo dalla Normandia, vengono realizzate sulla pelle di ulteriori vittime di questo gioco ipocrita e insensato.
«La storia della Guerra Fredda vede le sue radici nelle guerre precedenti», rileva l’accademico, raggiungendo la Berlino divisa. «Come disse il presidente Kennedy, “avere un muro è molto meglio che combattere una guerra”. Questa divisione originò in un certo senso stabilità, in Europa», dando inizio al processo d’integrazione europea, ratificato nel ’57 con il Trattato di Roma. È facile intuire come ormai i sei Stati fondatori avessero compreso «il costo della geografia». Uomini spinti dalla radice cattolica a «costruire ponti» per unire l’Europa; eppure, iniziano a proliferare gli Stati-nazione, che da 51 del 1945 passano ai 193 attuali.
Al pullulare di frontiere corrisponde un «enorme costo in termine di vite umane», in un equilibrio oggi sempre più precario ormai sul punto d’implodere. È il caso della Corea del Nord e del Sud che, pur non avendo mai stipulato un trattato di pace hanno raggiunto un compromesso - dopo ben 158 incontri - tuttora convivendo in alta tensione. Per non parlare della polveriera in Medio Oriente, dove Israele continua a combattere contro gli Stati Arabi. «Dopo la Guerra Fredda, quello che notiamo è una serie di allargamenti da parte dell’Unione europea». Contro quest’espansionismo si colloca «un giovane agente del KGB che, incredulo e disperato, aveva assistito al collasso dell’Unione Sovietica. Un uomo che trascorre il resto della sua vita cercando di ricostituire la potenza russa, divenendo presidente imperiale». Un risveglio amaro, per l’Europa già sfinita dalla crisi, oggi alle strette di fronte al bivio della difesa comune e di quell’ombrello nucleare da attuare senza il sostegno americano.
«Abbiamo ascoltato storie di confini che si spostano – conclude il docente di Storia contemporanea Tommaso Piffer - storie di sofferenze del XX secolo. All’origine c’è il peccato originale che conduce l’uomo a distruggere sé stesso. E tuttavia, c’è sempre qualcuno che dice “no”, che costruisce l’integrazione, o che considera il nemico un fratello, come Ungaretti. Come sostiene Vasilij Grossman, “a questi uomini bisogna guardare come a un faro di speranza”».
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.



Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione