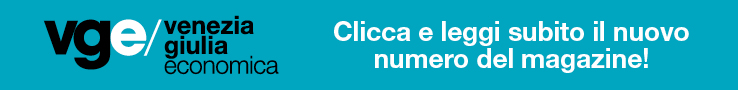ffilm festival
Le cicatrici della Shoah nella Amsterdam di oggi, èStoria premia Bianca Stigter

Il film approdato a Cannes lo scorso anno con la regia del londinese Anthony Queen, oltre 130 luoghi raccontati teatro della violenza nazista.
Le vite (spezzate) degli altri. L’acqua dei canali, in cui si nuota, dove si pattina quando si ghiaccia. La stratificazione degli anni, mostrata attraverso spaccati di case in cui un tempo vivevano gli ebrei deportati, oggi occupate da altri o demolite e inghiottite dalla Storia. È stato proiettato ieri sera presso il Kinemax di Gorizia - in prima assoluta in Italia - il lungometraggio “Occupied city”, approdato a Cannes lo scorso anno con la regia del londinese Anthony Queen e tratto dall’”Atlas of an occupied city. Amsterdam, 1940-1945” della compagna olandese Bianca Stigter. Dopo la calda accoglienza e ben cinque candidature accantonate, il documentario si è aggiudicato anche il Premio della IV edizione di èStoria film festival a Gorizia.
«Una costola cinematografica del tradizionale festival», come ha specificato ieri sera il presidente dell’associazione culturale èStoria Adriano Ossola. Una kermesse cinematografica parallela al panorama di conferenze, che grazie a questo «fiore all’occhiello» ha subìto «un’accelerata di qualità», ha osservato il critico cinematografico Paolo Lughi. «Stiamo cercando di crearci un nostro pubblico, quello degli appassionati di storia attraverso il grande schermo – così Ossola – La proposta di quest’anno è estremamente qualificante.
«Abbiamo pensato di proiettare alcuni dei film più significativi dal punto di vista del rapporto tra storia e cinema - ha rimarcato - apparsi lo scorso anno a livello internazionale. Produzioni che sono delle première per Gorizia e per l’Italia». La prima parte del lungometraggio – in lingua inglese con sottotitoli in italiano e della durata di quattro ore e mezza – è stata presentata alle 17, per poi proseguire dopo la premiazione di Stigter alle 20.30. Dal “Three minutes” – che Ossola definisce un «fascio di luce sulla shoah dell’Olanda», l’autrice approda a un soggetto scritto insieme a Queen, premiata «per aver fatto della conservazione della memoria il codice più riconoscibile».
Una collaborazione che unisce il linguaggio cinematografico e la narrazione storica in un documentario innovativo e senza precedenti. Una vera e propria «svolta nella storia del documentario», come ha rilevato Lughi. «In genere il documentario mostra riprese filmate dal vero, una documentazione di eventi storici accompagnata da un commento. Questo è invece un capostipite nel suo genere. Una perlustrazione della città di Amsterdam casa per casa, che mostra appartamenti, scuole, luoghi di un’Amsterdam attuale, che attraversa anche il periodo del Covid». Stigter condensa sulla carta ciò che Queen cristallizza nella pellicola, in un documentario che sublima il passato alla luce del presente.
Ricerca assidua della macchina da presa - che da uno scorcio di canale passa nell’intimità di una cucina - con l’obiettivo di scandagliare la memoria collettiva, chiamando in causa lo spettatore. «Il film parla da sé – ha sottolineato la scrittrice – Con poche parole lo spettatore fa i collegamenti, è un film aperto, che può essere interpretato in modi differenti». Lo stratagemma è non mostrare immagini d’archivio, ma una narrazione della storia sovrapposta all’Amsterdam odierna. «Era un’idea che Steve aveva già nel 2006 – ha raccontato – Quando me l’ha proposta ho trovato interessante presentare i fatti in maniera nuova. Qui si chiede allo spettatore di guardare oltre alla storia, in un modo nuovo».
Dall’ufficio di Isaac Keesing ci si ritrova in piazza principe Bernhard, quindi in piazza Rembrandt, dove un tempo sorgeva il locale “De Kroon” distrutto dai tedeschi. La voce narrante di Melanie Hyams ci conduce per mano da un luogo all’altro, senza interruzione di sorta, raccontando di deportazioni e suicidi mentre la vita scorre serenamente ai giorni nostri. Un parallelismo affidato al pubblico in sala, al quale spetta l’arduo compito di interiorizzare il dolore, sovrapponendo due epoche in contrapposizione. Da un lato la tragedia dell’olocausto e della morte, dall’altra la libertà di scivolare con lo slittino sulla neve al margine dei ponti. Dalla piazza Max Euw al numero civico 62 – poi chiamata Leidsekade – verranno trascinati via gli ebrei residenti.
«”Leidseplein completamente ripulita”, si legge in un articolo del partito nazista olandese, nel gennaio del 1941». Il parallelismo si riflette di rimando nella ripresa dei centri ricreativi chiusi a causa del Covid: «Chess game temporarily closed due to Covid-19», avvisa come un sinistro presagio la scritta in sovrimpressione. Mentre la voce narrante prosegue nel suo lugubre racconto. Continui rimandi, che spingono a riflettere, «a tenere alta l’attenzione, affinché queste situazioni non si ripresentino», ribadisce Lughi. E ancora, Apollolaan, al civico 123. Un tempo pensione di proprietà della famiglia Josephs, «tutti morti ad Auschwitz nel 1942», rammenta Hyams, mentre un tenero orsacchiotto campeggia stridente in primo piano.
Diventerà una pensione per i tedeschi, poi requisita in seguito al bombardamento del quartier generale nel novembre del 1944. È il 15 maggio del 1940, le truppe tedesche si avvicinano ad Amsterdam da est ed entrano in città attraversando il ponte Berlage sul fiume Amstel. Un bambino gioca in una pozzanghera, presso Museumplein – un tempo sede del Club di pattinaggio sul ghiaccio – Qui si preparano a marciare le camicie nere dell’NSB insieme a Heirich Himmler, in un eterno passato presente. Le ville sul lato est della piazza diventano i quartieri generali dell’amministrazione militare e civile tedesca.
Sarà solo nel 1953 che i bunker tedeschi verranno fatti saltare in aria. Un Paese, l’Olanda, con la percentuale più alta – 75% - di ebrei uccisi: «Nella sola Amsterdam vengono uccisi più di 60mila ebrei». Una città che ha assistito inerme anche al dramma terribile di Anna Frank, qui appena accennata, scegliendo deliberatamente di mostrare «il dramma della quotidianità, di famiglie che non abbiamo conosciuto», ancora Lughi. «Si voleva dare risalto alle storie di gente comune, piccole storie – ha evidenziato Stigter – Come se realmente stessimo passeggiando per la città. Perché ad Amsterdam c’erano altre persone, oltre ad Anna Frank, e su questo io e mio marito abbiamo discusso».
Non può mancare all’appello il Rijksmuseum, con le sue preziose tele, trasferite nel 1939 in chiese e altri edifici dell’Olanda Settentrionale, a campeggiare attraverso dettagli materici ingranditi sullo schermo. Oltre 130 i luoghi mostrati nel film, a dispetto dei 2mila nominati nel libro, ripresi e presenti in sequenze tagliate. «Tutti i luoghi sono stati filmati, ma saranno presentati attraverso installazioni artistiche in futuro».
Foto Bumbaca
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram e Whatsapp, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.









Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione