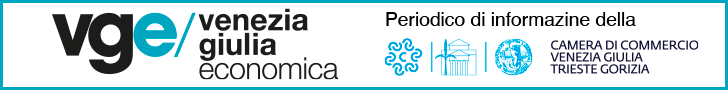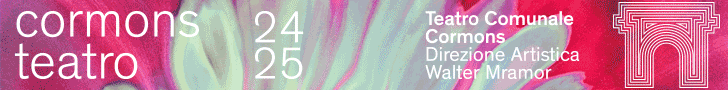l'intervista
Lala e le sue identità, la regista a Gorizia: «Grande cultura della comunità rom»

La regista Fales sarà ospite domani sera al Kinemax per presentare il suo film: «La società è profondamente cambiata, servono nuove riflessioni».
Identità cercate, volute, necessarie. In un mondo dominato dalla globalizzazione e in cui la mobilità – non solo fisica e geografica ma anche di genere e pensiero – è elevata, permane il vincolo dell’identificazione in qualcosa di preciso. Categorie che spesso si rifuggono, dicotomie che spesso sono causa di tensioni (migranti/cittadini, italiano/straniero) perché ancora troppo spesso legate a pericolosi accostamenti: legale/illegale, lecito/illecito, regolare/irregolare.
Di tutto questo parla “Lala”, docufilm di Ludovica Fales che verrà presentato domani alle 20.30 al Kinemax di Gorizia come prima tappa del tour nelle sale cinematografiche. A introdurre la visione del film, che verrà oggi proiettato alla 35esima edizione di Trieste Film Festival per il Premio Corso Salani, saranno Simone Dotto, docente al Dams dell’Università di Udine, la regista Ludovica Fales, gli interpreti della pellicola Ivana Nikolic e Miguel Lebbiati assieme ai produttori Igor Princic e David Cej.
L'opera, che ha come special track musicale “Il Mio Nome è Lala” di Assalti Frontali, feat. Luca D’Aversa, ha vinto il Premio del pubblico Mymovies alla 41esima edizione del Bellaria Film Festival, ha ricevuto la menzione speciale per il documentario alla XV edizione di Ortigia Film Festival e risulta ora in selezione ufficiale ai Nastri d’Argento Documentari per la sezione Cinema del Reale.
Il film parte dal racconto della vita di tre giovani donne che l’Italia non riconosce perché figlie di migranti, ma l’orizzonte si allarga poi fino a trasformarsi in un viaggio collettivo alla ricerca dell’identità di un’intera generazione dai diritti indefiniti o negati. Per avere una traccia su ciò che potremo vedere domani sera abbiamo rivolto alcune domande alla regista Ludovica Fales intercettandola nel suo viaggio verso Trieste.
Come è nato questo progetto?
Il progetto nasce da un incontro con Zaga, la ragazza che si vede all’inizio e in alcune altre scene del film. Ci siamo conosciute quando aveva diciassette anni, sull’orlo della maggiore età quindi in un momento di grande gioia e cambiamento, ma questa gioia è stata presto interrotta dalla consapevolezza che non avrebbe mai ottenuto i documenti che sperava invece di avere facilmente. La situazione dei suoi genitori, come di molti altre persone giunte dalla ex Jugoslavia durante la guerra, li portava a trovarsi in una condizione di sospensione giuridica perchè non avevano potuto portare con sé i documenti e non era semplice ricostruire da dove farli arrivare dato il cambiamento della struttura politica-amministrativa che nel frattempo era intervenuta.
Lei quindi è rimasta bloccata e come lei decine di migliaia di ragazzi, ma questa è una storia che di fatto riguarda tutti quei minori che nascono e crescono in Italia e non hanno il diritto alla cittadinanza, ritrovandosi per varie ragioni incastrati in questo status che sicuramente almeno in parte lo ius soli potrebbe risolvere. Il film poi si è sviluppato in una direzione inaspettata perché quando Zaga si è allontanata da Roma per cercare i documenti, cercando di arrivare in Serbia, mi sono sentita la responsabilità di continuare a raccontare la storia e ho così raccolto un gruppo di giovani che avevano avuto esperienze simili: insieme a me hanno costruito una sceneggiatura basata su una serie di improvvisazioni nelle quali le loro memorie e le loro storie sono state riattivate.
Come è entrata in contatto con Transmedia?
Partecipavo a un workshop di cinema in Spagna organizzato dall’associazione European Women’s Audiovisual Network dove ho conosciuto Manuela Buono, una produttrice e distributrice di Trieste che mi ha messo in contatto con Igor Princic. In realtà lo avevo anche già conosciuto a Gorizia perché qui ho compiuto parte del mio percorso accademico.
Perché ha scelto la forma del docufilm?
Non so se sia la definizione più adatta perché è un prodotto ibrido, che mescola realtà e finzione in modo sicuramente sui generis. L’ho scelto perché è emerso dal processo: è nato come documentario di osservazione, è diventato un progetto di improvvisazione da cui ha preso vita un film di finzione. Poi quando Zaga è rientrata in Italia e si è fatta nuovamente sentire ho deciso che fosse importante far rientrare il suo punto di vista per cui ho inserito una nuova parte documentaria. Questa scelta in verità è dettata anche dal desiderio di mettere lo spettatore di fronte a domande sullo statuto delle cose che vediamo cercando di capire dove si colloca la questione del rapporto con la realtà.
Il premio ottenuto al Bellaria Film Festival può avere maggiore impatto sulla storia raccontata o sull’importanza della forma cinematografica che ha scelto?
Spero sulla storia: ha dato molta visibilità ai protagonisti e per noi era molto importante. Ha dato poi la possibilità al film di esistere e avere un supporto forte perché il premio è sempre l’occasione di rendere meritevole agli occhi degli altri ciò che viene premiato. Il suo lavoro affronta il problema della necessità di avere una cittadinanza specifica in un momento in cui, in realtà, la maggior parte di noi si considera cittadina del mondo.
Essere cittadini del mondo e avere la possibilità di avere dei diritti perché si ha una cittadinanza non sono aspetti incompatibili. Attualmente viviamo in una forma di stato nazionale che richiede che i diritti siano collegati alla cittadinanza nazionale. A questo certo dovremmo dedicare una riflessione, se sia cioè il modo più adatto di rispendere alla nostra contemporaneità. Sicuramente perché si arrivi a pensare a una cittadinanza transnazionale bisogna concepirla in forma fortemente inclusiva: il film lancia un messaggio sulla questione della transnazionalità nel momento in cui parla di tutte le multiformi identità vissute da ognuno dei ragazzi che ha partecipato al progetto perché sono sì italiani ma pure rom e culturalmente legati al Paese di provenienza dei loro genitori.
Parliamo delle etichette: quelle relative alla cittadinanza, al genere e quanto queste siano limitanti ma anche in alcuni casi importanti per le persone,che tendono a volersi riconoscere in qualcosa.
Ognuno di noi ha la propria identità: abbiamo deciso che deve rispondere a delle strutture concettuali che non consentono facilmente di abbracciare più di una identità e questo è un concetto molto monolitico che corrisponde anche a una visione della cultura piuttosto monolitica. Per fortuna il post-strutturalismo ha lavorato su come non esista una sola ma tante culture, non una ma tante identità che rispondono a una molteplicità di strutture concettuali. Il fatto che ci troviamo ancora a dibattere di questo con tanta tensione nella scena pubblica è quasi bizzarro, perché siamo andati molto oltre una visione che vede un’unica possibilità di definire il concetto di cultura come aderente a quella nazionale. Anche per quanto riguarda il genere e altre categorie, penso che il fatto che si stiano ridiscutendo sia il segno che la società è profondamente cambiata e necessita di nuove riflessioni.
A Gorizia non esiste una comunità rom: può parlarci della sua esperienza con questa realtà?
Anche in questo caso esistono tante persone diverse con esperienze diverse. C’è però una narrazione univoca, quella che proviene dai media che negli ultimi quarant’anni hanno sottolineato soprattutto certe caratteristiche e hanno criminalizzato la comunità rom, facendo sì che nella percezione generale sia considerata una comunità solo con tratti negativi. In realtà a Roma esistono tante comunità rom diverse con storie, condizioni di vita, sociali e relazioni interculturali differenti. Penso che prima di tutto bisognerebbe aprirsi ad ascoltare le voci multiformi all’interno della comunità rom italiana che è plurale e la sua multiculturalità crea una ricchezza molto forte, da difendere. La sua grande capacità di assorbire stimoli culturali diversi va protetta e considerata un patrimonio estremamente positivo.
Personalmente cosa ha tratto da questo lavoro?
Per me è stata un’esperienza straordinaria di incontro e conoscenza che ho avuto la possibilità di condividere con i ragazzi che hanno fatto questo film. Si è trattato di un lungo percorso durante il quale ci siamo conosciuti, raccontati, posti moltissime domande e quindi tutte le riflessioni che ho fatto non sono di carattere teorico ma di esperienze reali, frutto di incroci e incontri relazionali, emotivi.
La quantità di possibili modi di essere è ciò che secondo me rende il mondo contemporaneo un luogo interessante senza che questo implichi perdersi o perdere punti di riferimento: attraverso la conoscenza reciproca e lo studio dei percorsi di ciascuno, la capacità di ascoltarsi, di includere e mettere in comune le esperienze si può creare una società ricca e composita guardando a un futuro più interessante di quello prospettato da chi vuole difendere un mondo che non deve cambiare e si radica su posizioni di difesa. Siamo in transito, viviamo tra tante frontiere e questo ci arricchisce e rende aperti. In una parola: unici.
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram e Whatsapp, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione